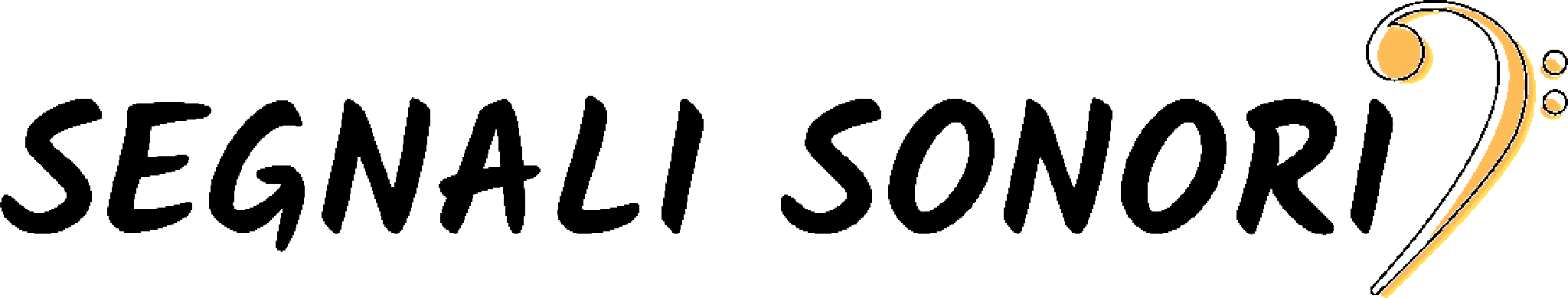– Sono tornati quegli irresistibili birichini con la passione per lo ska. In “Theatre of the Absurd Presents: C’est la vie” attingono alle opere esistenzialiste della metà del XX secolo. «Abbiamo litigato tanto su tutto, ma ci siamo divertiti a suonare di nuovo assieme»
– «Oggi però non ci interessa più vendere dischi o arrivare in cima alle classifiche, ma suonare dal vivo, incontrare la nostra gente: siamo una band nomade in tour perenne con una tribù sparsa per il mondo pronta ad accoglierci»
– La storia di un gruppo di proletari inglesi. «La band era uno dei modi per uscire da quella realtà. Le alternative erano tassista, pugile, calciatore o gangster. La band è diventata una sorta di bizzarra famiglia surrogata. Venivamo tutti da genitori single. Ed è stato come una terapia»

Sono tornati quegli irresistibili birichini dei Madness. Occhiali scuri, qualche ruga e qualche acciacco in più, imbolsiti, ingrigiti, più che una band ormai sono uno stato mentale, i capostipiti di una tribù che sembrava dovesse estinguersi più di quarant’anni fa e che invece non ne vuol proprio sapere di sparire: alla fine degli anni Settanta, i Madness parevano essere solo sette proletari inglesi con la passione per lo ska, figli del revival mod del periodo e destinati soltanto a qualche stagione di gloria. Niente di più sbagliato. A quasi cinque decenni di distanza dai primi successi, rimasti in sei, quegli ex ragazzi londinesi sono ancora in piena attività.
«Essere nei Madness è un grande privilegio», racconta Carl “Chas Smash” Smyth, che dal 1979 suona la tromba nella band. «La gente nutre un incredibile affetto nei nostri confronti anche dopo così tanti anni perché sa che, per quanto disfunzionale possa essere, la nostra è sempre una grande famiglia. Oggi però non ci interessa più vendere dischi o arrivare in cima alle classifiche, ma suonare dal vivo, incontrare la nostra gente. Mi piacerebbe che i Madness diventassero come i Grateful Dead: una band nomade in tour perenne con una tribù sparsa per il mondo pronta ad accoglierci».
Sono passati quarantacinque anni dal loro primo e più grande successo One Step Beyond, ma i Madness restano sinonimo di musica ska, con quello che loro stessi hanno definito «nutty sound», più o meno «suono pazzoide». Dopo vari cambi di formazione e lunghe pause, la band inglese è tornata quest’anno con un nuovo album d’inediti, il cui titolo e la cui copertina sono tutto un programma: Theatre of the Absurd Presents: C’est la vie lascia intendere la gioiosa sfilata che attende i curiosi, mentre la cover è irrimediabilmente grottescamente stupida. Follia, allo stato puro, invecchiata da quarantacinque anni in botti di birra ambrata, considerata in patria come un vero gioiello del patrimonio.
Il sestetto di sessantenni dal buon passo e dalla buona vista nonostante le loro sagome inamidate, con questo tredicesimo album offre ancora un’abbagliante e sorprendente lezione di musica. Quando pensavamo fossero già cotti e musealizzati, ecco un disco denso (cinquantasette minuti, tre atti, quattordici titoli e sei intermezzi parlati) che unisce la secolare raffinatezza del music hall inglese con la tradizione pop satirica.
Come suggerisce il titolo, è un concept album, forgiato nella noia e nel terrore della pandemia, come una sorta di Sgt Pepper con distanziamento sociale. È il loro disco più maturo: l’energia caotica della gioventù lascia il posto a un tono più riflessivo. La voce di Graham “Suggs” McPherson è un po’ burbera, ma invariata. La gestazione dell’album è stata piena di tensioni. Come si legge nelle note di copertina: «Dopo un paio d’anni disparati che hanno visto la band nella sua forma più frammentata, i Madness si sono riuniti in una zona industriale a Cricklewood all’inizio dell’anno, dove Suggs, Mrk, Chrissy Boy, Mike, Lee e Woody si resero conto che ciò che li univa era sempre più grande di ciò che li divideva. «Dev’essere amore, o forse più appetito per la distruzione», commenta Suggs.
«La mia band era come un microcosmo della società», racconta il cantante dei Madness. «Eravamo in disaccordo su tutto – dalla vaccinazione al lockdown – al punto che mi chiedevo se saremmo davvero tornati insieme. Quando non puoi parlare faccia a faccia, tutto è esagerato. C’erano momenti in cui ero infuriato con gli altri. Litigare per posta elettronica è estenuante. Non volevo la Brexit, ero a favore dei vaccini e ho seguito tutte le regole del lockdown, poi è arrivato Boris e mi ha tolto il tappeto da sotto i piedi. Ero totalmente in disaccordo con alcune opinioni della band, ma ognuno ha scritto dei propri sentimenti in quel particolare momento. In definitiva non abbiamo uno sfogo politico, siamo una pop band, ma abbiamo sempre avuto un significato nascosto e più oscuro. Inconsciamente, abbiamo sempre avuto una sorta di bussola morale».
Le differenze sono svanite non appena tornati in studio. L’idea di un teatro dell’assurdo, dalle opere esistenzialiste della metà del XX secolo – come Aspettando Godot di Beckett – in cui la comunicazione si interrompe, è diventata il filo conduttore dell’album, dati i suoi evidenti parallelismi con il Covid.
Il lockdown non è stato certo la prima volta che i Madness hanno tentato di mettere tutto insieme. Si sciolsero per la prima volta nel 1986, logorati dal ciclo incessante di registrazioni e tour, soprattutto come band nota per portare la festa. Si erano formati alla fine degli anni Settanta quando Suggs, nato Graham MacPherson, lavorava alla Quintin Kynaston, una grande azienda nel nord di Londra. Sua madre, una cantante jazz, lo aveva cresciuto da sola dopo che suo padre se n’era andato quando Suggs aveva tre anni. La famiglia viveva una vita peripatetica, spostandosi di città in città. «Da bambino, non avevo un cazzo», ricorda. «Un appartamento senza servizi igienici. Sono dovuto andare a vivere con mia zia in Galles perché era così disfunzionale che mi avrebbero portato via».

Sebbene fosse un bambino «ferocemente intelligente», una volta tornato a Londra si imbatté nel gruppo sbagliato e alla fine abbandonò gli studi da adolescente. «È stato un miracolo incontrare la band», confessa. «Avevamo tutti lo stesso tipo di background, ed era uno dei modi per uscire da quella situazione. Le alternative erano tassista, pugile, calciatore o gangster. Non ho avuto la perspicacia per farne nessuno. La band è diventata una sorta di bizzarra famiglia surrogata. Venivamo tutti da genitori single. Ed è stato come una terapia». Grazie alla band, Suggs superò anche i problemi con la droga. «Prendevo molta ecstasy. Ho perso la testa».
Suggs, incarna la visione di Londra come un luogo in cui una banda di sfacciati ragazzi della classe operaia possono cantare canzoni a scuola e a casa e adattarsi e trovare un vasto pubblico. Camden Town, a cui Suggs è indissolubilmente legato, incarna il cambiamento. Ricorda Chrissie Hynde, dei Pretenders, venuta da Chicago e rimasta sorpresa dal livello di libertà di cui godevano i giovani musicisti a Londra. «Non riusciva a credere che si potesse ricevere il sussidio di disoccupazione, vivere in uno squat e che i trasporti pubblici fossero così facili, e che si potesse provare sotto un arco ferroviario. Ora, non lo so. Ci sono sempre sbocchi. Ho visto registrare brani sulla tromba delle scale di un condominio con i telefoni cellulari. Ma i gruppi stanno diventando sempre più difficili».
I Madness, invece, tornano a rimbombare: nel nuovo album, nei live, online. Anche su Spotify, il cui fondatore non era nato quando i Madness erano al loro apice: Our House conta più di un quarto di miliardo di ascolti.
«Mi piace esibirmi più di prima. Quando ero bambino, l’adrenalina… e il solfato [di anfetamine] significavano che c’era una macchia di sudore, braccia, gambe e cappelli che volavano nell’aria. Non sei completamente consapevole di ciò che sta accadendo. Ora guardo e vedo che il pubblico apprezza davvero ciò che facciamo. È una cosa straordinaria. Abbiamo avuto venti canzoni nella top 10. È una cosa così effimera, la musica pop, dura solo tre minuti, ma quelle canzoni sono il tuo primo bacio, il tuo primo litigio, la tua prima sigaretta», riflette Suggs. «L’altra caratteristica della musica è che dopo devi fare un passo indietro per darle un’occhiata. Quando abbiamo finito l’album non ero sicuro che fosse buono. Ma poi ascolti una canzone e pensi “va bene”. Tutto si riduce all’impegno che metti. Questo è quello che abbiamo sempre fatto».
E cosa pensa quando si ferma a guardare l’intero progetto Madness? Lui sorride. «Beh, come ha detto il mio amico: “Penso che tu sia una delle tre migliori band al mondo”. Non riesco proprio a pensare quale siano le altre due».