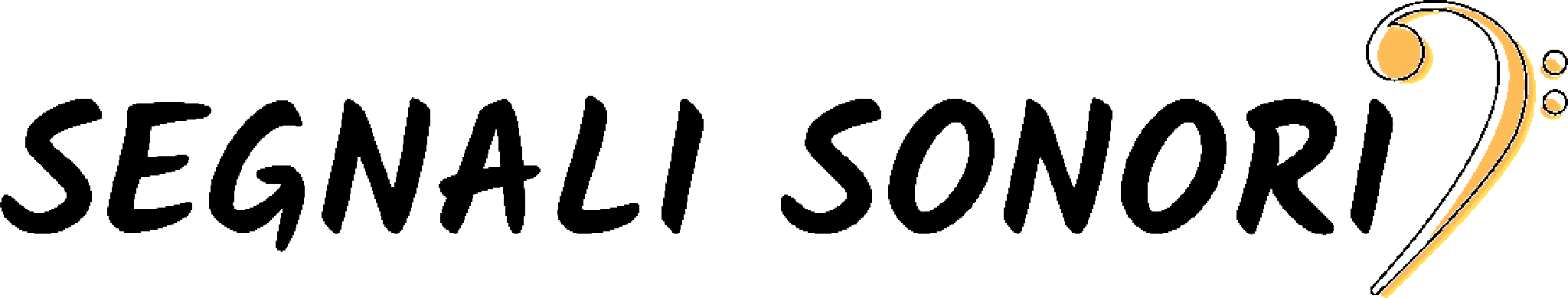– Fu il complimento che Pino Daniele rivolse al profeta del reggae al leggendario concerto a San Siro del 1980, inizio di un grande legame con l’Italia che spiega l’exploit del biopic di Reinaldo Marcus Green
– A più di 40 anni dalla morte, il musicista giamaicano continua a irradiare la sua potenza. La sua musica si è mantenuta attuale attraverso il dub, il sound-system e il ragamuffim. I suoi album entrano in classifica a ogni ristampa
– Il successo al botteghino ribadisce anche il fascino che le storie delle vite celebri hanno sul pubblico: nelle biografie di artisti, scienziati, condottieri, registi e sceneggiatori trovano storie avvincenti da raccontare al pubblico
Se non fosse morto quarantatré anni fa, adesso Bob Marley avrebbe 79 anni. Anche se in Jamaica c’è ancora molta gente che continua a credere che il “re del reggae” non è mai nato, e quindi non è mai morto: perché, come l’imperatore Hailé Selassié, è un erede diretto di Jah.

E, come un Messia, anche a più di quarant’anni di distanza dalla sua morte così prematura, l’icona di Bob Marley continua a irradiare la sua potenza, come dimostra il successo al botteghino, in Italia come negli Stati Uniti, del biopic Bob Marley – One Love. Un exploit che conferma anche il fascino che le storie delle vite celebri hanno sul pubblico: da Bohemian Rapsody ad Oppenheimer, da Elvis a Priscilla, da Mia Martini a Califano. È nelle biografie di artisti, scienziati, condottieri, dove registi e sceneggiatori trovano storie avvincenti da raccontare alle platee di tutto il mondo. Una è, appunto, quella di Bob Marley, la cui morte, nel maggio del 1981, ha lasciato un vuoto incolmabile che ha risucchiato anni di lavoro e di propaganda rasta, portata avanti dal principe nero e dagli altri fratelli shamani. C’è stato come un improvviso silenzio, la fine di una lunga pulsazione in levare. Alle sue spalle l’autore di No Woman No Cry non ha lasciato autentici eredi musicali capaci di mantenere viva la fiamma del reggae, una musica la cui ascesa e caduta è coincisa con la breve e folgorante parabola di Marley.
Ma il reggae è una musica senza tempo. Una musica che dura comunque, che, come il suo popolo, sa adattarsi ai tempi che cambiano, sa resistere alla violenza, alla frustrazione, alle “mode di Babilonia”, alla colonizzazione e all’emigrazione.
Bob Marley ha acceso un fuoco che è difficile spegnere, qualcosa che ha a che fare con l’energia pura, elementare, vitale: «La musica quando dà le vibrazioni giuste, non la puoi fermare», diceva. «E il reggae sarà la musica dei “rude boys” di tutto il mondo. Specialmente il dub, che è il cuore del reggae». E, infatti, oggi i ragazzi di mezzo mondo continuano a tramandare questa musica sotto forma di dub, di sound-system (base di basso e batteria sulla quale improvvisa il deejay) o di ragamuffin che assomiglia un po’ al rap.
Bob Marley morì la mattina dell’11 maggio 1981 al Cedar of Lebanon Hospital di Miami, il cancro non gli aveva permesso di vedere per l’ultima volta la sua Giamaica. Il decorso era stato purtroppo velocissimo: durante un tour aveva avuto un collasso al Central Park e, dopo un drammatico ricovero in una clinica di Monaco di Baviera specializzata in malattie terminali, aveva deciso di tornare a casa. Ma le sue condizioni peggiorarono in volo e così fu costretto a trascorrere le sue ultime ore nell’ospedale di Miami. Aveva solo 36 anni.
Sotto molti aspetti “Tuff Gong”, il soprannome che si era guadagnato nelle strade di Trenchtown, il ghetto di Kingston, la capitale e maggiore città giamaicana dove era cresciuto, è una figura unica nella storia musicale e non solo del Novecento: figlio di un padre bianco e di una ragazza nera, da “mezzo sangue” discriminato è diventato un leader politico e spirituale per la Giamaica, è stato la prima superstar della musica del Terzo Mondo. È difficile trovare nelle cronache della musica popolare un personaggio che sia riuscito a trasmettere un simile messaggio di fratellanza e di pace, a rendere così chiara la capacità trascendente di un concerto. Marley ha compiuto con il reggae un’operazione paragonabile all’opera di evoluzione e popolarizzazione svolta dai Beatles sul pop.
I suoi dischi, che coprono un arco temporale che va dal 1965, esordio con i Wailers, al 1980, continuano a finire in classifica ad ogni ristampa, e il 24 maggio Island/UMe pubblicherà una speciale edizione limitata dell’intramontabile album di Bob Marley: Exodus, definito «il miglior album del XX secolo».
Una vicenda così non può essere spiegata soltanto con argomenti musicali: è chiaro che Bob Marley ha compiuto con il reggae un’opera di allargamento dei confini di genere arricchendolo di echi soul e pop. Mentre Eric Clapton faceva conoscere al mondo intero uno dei primi hit composti dal padre del reggae, I Shot The Sheriff, il celebre discografico Chris Blackweel, patron della Island, lo introdusse al mercato inglese e americano. Cominciò così l’ascesa verso il successo internazionale: arrivano brani ormai entrati nella storia come No Woman No Cry, Get Up Stand Up, Rastaman Vibrations, album come Exodus, Kaya, Survival e il celebre Live. Il reggae diventò una sorta di colonna sonora degli anni Settanta: l’industria del rock ne scopre i suoni, i Police conquistano le classifiche internazionali adattando ai gusti “bianchi” il ritmo della musica caraibica. Per la Giamaica Bob Marley assurge a un vero e proprio idolo, anche perché, nonostante il successo internazionale, non abbandonò mai i principi etici e religiosi dei “rasta”, non limitandosi soltanto ad esibirne i simboli più vistosi, copricapo colorato, i lunghi capelli in treccine, i “dreadlocks”, macroscospici joint di “ganja”, considerati uno strumento di comunicazione con Dio.

Ma, al di là del suo talento artistico e dei musicisti che suonavano e collaboravano con lui, era la sua personalità di leader naturale a fare la differenza, rendendolo davvero un artista che aveva una missione dove una profonda religiosità – era un convinto rastafari – si sposava con un’altrettanta profonda coscienza politica in una piccola isola devastata dalla povertà e dalla violenza tipiche di quei Paesi che sono formalmente indipendenti ma che in realtà rimangono prigionieri delle regole del più cinico colonialismo.
Questo impegno rischiò di costargli la vita nel 1976, quando già i suoi brani erano in testa alle classifiche di mezzo mondo, in un attentato in cui lui riportò ferite lievi, ma sua moglie Rita e il suo manager furono colpiti in modo grave. Attentato che è il punto di partenza del film di Reinaldo Marcus Green, prodotto da Brad Pitt. Costretto a un breve esilio a Londra, due anni dopo e proprio grazie a Marley, andò in scena One Love Peace Concert, un evento organizzato per tentare di porre fine a una guerra civile di fatto tra i sostenitori dei due principali partiti, il Jamaica’s Labour Party e il People’s National Party, culminato con i due leader nemici sul palco convinti proprio da Marley a stringersi la mano.
In quella musica apparentemente semplice, scandita dal ritmo in levare e da una ritmica che vive di un gioco di spazi tra la batteria e le linee di basso, c’è un altrove che l’ha resa un linguaggio universale, che quasi per osmosi ha stabilito un contatto tra i suoni del Sud del Mondo ma al tempo stesso ha messo radici profonde nella musica degli anni a venire, dalle operazioni più sofisticate ai prodotti commerciali.
L’Italia ha amato profondamente da subito Bob Marley e il Reggae, assimilando nell’anima collettiva quel messaggio di pace, amore, uguaglianza, libertà. C’è una data che riassume questa storia straordinaria: il 27 giugno 1980. Dopo il buio degli anni di Piombo, dopo il lungo periodo in cui l’Italia era stata cancellata dalla mappa dei tour internazionali per ragioni di sicurezza, San Siro, la “Scala del calcio”, apriva le sue porte alla musica per il “Profeta del reggae”. Ufficialmente c’erano 80mila persone, ma probabilmente erano di più: tutti erano li per vivere insieme un rito di fratellanza collettivo che ha segnato per sempre la storia della musica dal vivo del nostro Paese e la vita di chi c’era. Ad aprire il concerto era stato Pino Daniele che incontrò Marley nel backstage e gli rivolse un complimento che solo grazie alla potenza del dialetto riassume un’avventura così straordinaria: “Bob! Si Gruoss!”. (Bob sei un grande).