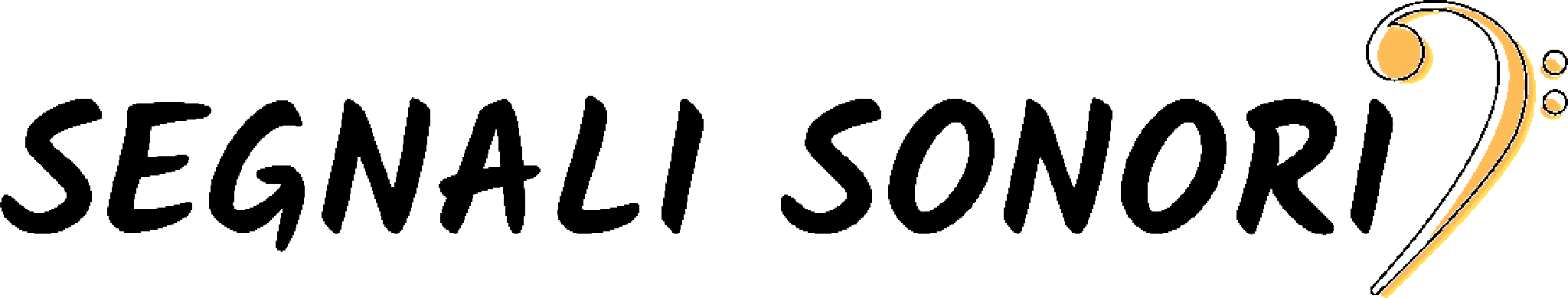In occasione del concerto della Big Band a lui intitolata, che il prossimo 17 novembre aprirà la XXXIX stagione concertistica di Catania Jazz, abbiamo chiesto ad alcuni musicisti un ricordo del grande contrabbassista nato 100 anni fa e scomparso a soli 56 anni. Rispondono Boris Kozlov, attuale direttore musicale della Mingus Big Band, Stefano D’Anna, Nello Toscano, Peppe D’Argenzio e Esperanza Spalding
Charles Mingus era tutto: jazz, folk, danza, teatro, proprietario dell’etichetta, coraggioso uomo di colore. In un’epoca in cui le opinioni contrarie potevano farlo uccidere o, almeno, esiliare dal mondo della musica, si è espresso con coraggio ed esorcizzando forti emozioni attraverso le corde del suo contrabbasso. Il suo stile era feroce, quasi violento, come se il trauma del razzismo americano lo attraversasse.
Nato 100 anni fa a Nogales, Arizona, lungo il confine tra Stati Uniti e Messico, Charles Mingus Jr. è stato un personaggio difficile. Dolce e violentissimo, colto e ingenuo, pieno di contraddizioni e di appetiti insaziabili. Portava le stimmate del sangue diverso – nero, bianco, giallo, pellerossa – e del triste sobborgo di Los Angeles dov’era cresciuto. Peggio di un bastardo intitolò la sua autobiografia. Che inizia con un pugno nello stomaco al lettore: «In altre parole io sono tre. Il primo, sempre nel mezzo, osserva tutto con fare tranquillo, impassibile, e aspetta di poterlo raccontare agli altri due. Il secondo è come un animale spaventato che attacca per paura di essere attaccato. Il terzo infine è una persona gentile, traboccante d’amore che lascia entrare gli altri nel sancta sanctorum del proprio essere e accetta di lavorare per pochi soldi o anche gratis, e quando si accorge di cosa gli hanno fatto gli viene voglia di uccidere e distruggere tutto quello che gli sta intorno compreso se stesso per punirsi di essere stato così stupido. Ma non può farlo, allora torna a chiudersi in se stesso». Tutti e tre i personaggi sono reali, sosteneva Mingus, e una delle sue ballate più memorabili è Self-Portrait in Three Colors.
Mingus ha vissuto, scritto e suonato il suo strumento in uno stato di brillantezza agitata, mossa. Ha ampliato i poteri melodici del contrabbasso e ha trovato nuovi modi per fargli conquistare un ruolo di protagonista. Come compositore, ha portato l’erudizione blues di Duke Ellington in ogni gruppo che ha guidato, siano essi sestetti o orchestre complete. E ha mantenuto i suoi gruppi sciolti come un gruppo di amici che scherzano attorno al tavolo da gioco.
Quando pubblicò il suo album più celebrato, Mingus Ah Um, nel 1959, era sia un protagonista del jazz sia un anziano statista sulla scena di New York. Ma i suoi anni decisivi dovevano ancora arrivare: la musica di Mingus alla fine sarebbe diventata difficile da dissociare dagli anni Sessanta, probabilmente perché trasmette in modo così potente una sensazione di cambiamento convulso. Ha fatto sentire la reinvenzione e la ricrescita come un rituale e una festa, fino alla sua morte nel 1979, a 56 anni.
Molto sensibile, sul palco aveva talvolta un carattere irascibile con la sua band, tanto da conquistarsi l’appellativo di “Angry Man of Jazz”. L’eredità di Mingus è rappresentata al meglio dalla bellezza indisciplinata delle sue registrazioni, tra cui The Black Saint and the Sinner Lady, un coraggioso album del 1963 pieno di radici del gospel battista e del blues. Voleva allontanarsi dalle etichette che divoravano la musica nera imprigionandola in scatole prescritte. Era rabbia, bellezza e caos.
Abbiamo chiesto un ricordo di Mingus, nel centenario della sua nascita, ad alcuni musicisti jazz che hanno lavorato con lui o che lo hanno vissuto in modo indiretto.
Boris Kozlov
Bassista, direttore musicale della Mingus Big Band, 54 anni

Non è facile indossare i panni di una leggenda e Charles Mingus ha delle scarpe enormi da calzare. L’iconico bassista e compositore jazz ha lasciato un corpus di opere così imponente, così complesso e così unico che ci vuole un musicista altrettanto raro per trasmetterne lo spirito. La musica di Mingus sopravvive attraverso la Mingus Dynasty, la Mingus Orchestra e la Mingus Big Band che il prossimo 17 novembre al Teatro Abc aprirà la XXXIX stagione concertistica di Catania Jazz. Tutte le band sono supervisionate dal bassista Boris Kozlov, che è anche arrangiatore e direttore musicale per i gruppi.
Kozlov è nato a Mosca durante il regime sovietico e ha iniziato i suoi studi di pianoforte. Alla fine, ha trovato la sua vera vocazione al basso e ha vinto il Concorso della Gnesin Music Academy per entrare al college a soli 15 anni, dove ha studiato basso elettrico. Dopo aver scontato i suoi due anni obbligatori nell’esercito sovietico, è stato assunto dallo Studio Ensemble “Melodia” di proprietà dello Stato. Ha vinto il primo Concorso per solisti jazz dell’allora Urss nel 1991, che lo ha costretto ad espandere la sua carriera alla scena jazz di New York City.
Kozlov è cresciuto nell’adorazione di Mingus. «Lui aveva emozioni che lo attraversavano come un uragano. Ho sentito storie di quando si sarebbe infuriato per qualcosa e avrebbe licenziato tutta la sua band, quasi sul palco. Poi il giorno dopo piangeva, si scusava e si metteva in ginocchio», ricorda. «Quello che mi viene in mente è che è sempre stato onesto. I ragazzi che hanno lavorato con lui hanno detto che non ci sono mai stati problemi logistici o di denaro. Tutto era davvero chiaro. Certo, era molto esigente con le persone. Cercava di elevare o far emergere lati delle persone che non si aspettavano di avere. A volte spingere un po’ aiuta, cosa che cerco di tenere a mente come bassista nella band Mingus. Sto solo spingendo un po’ in più. È la parte che fa suonare la musica e fa una vera vibrazione».
Le composizioni di Mingus continuano a sfidare i musicisti. «Con diverse cose, era molto in anticipo sui tempi, ma ora alcune di queste sono diventate comuni nel linguaggio del jazz moderno, come le note non armoniche, il cromatismo, i tempi mutevoli e così via», prosegue Boris Kozlov, il direttore della Mingus Big Band, vincitrice di un Grammy. Tuttavia, Kozlov sottolinea la difficoltà delle linee di basso in composizioni di Mingus come Children’s Hour of Dream e Little Royal Suite. «Sono ancora attratto dall’immediatezza e dalla passione con cui scriveva e suonava», aggiunge. «Anche dalla componente blues dei suoi lavori».

Stefano D’Anna
Sassofonista, compositore, 62 anni
«È stato dopo aver visto il suo concerto a Palermo nel 1976 che ho deciso di dedicare la mia vita al jazz», confessa Stefano D’Anna, palermitano con cattedra a Cagliari. Lui suona e insegna sassofono e quella sera di 46 anni fa è stato il sax tenore di George Adams a folgorarlo. «Era il quintetto dei due album-capolavoro Changes One e Changes Two, con Dannie Richmond alla batteria», ricorda D’Anna. «Vennero per tre giorni a Palermo, dal 26 al 28 marzo, tenendo sei concerti: due al giorno, uno pomeridiano e l’altro la sera. Stavamo in 150 stipati in un vecchio scantinato in via Duca della Verdura, che era la sede del Brass Group. Fu una stagione per me davvero emozionante: Lee Konitz, Charlie Ventura, Sal Nistico, Ornette Coleman, Charles Mingus. In quella situazione avevi i musicisti a pochi metri. Era una condizione ideale. Il quintetto di Mingus eseguì i pezzi di Changes One e Changes Two, pezzi molto lunghi, che dal vivo diventavano più lunghi. È stata una esperienza intensa. Il fatto di vedere George Adams mi diede la spinta definitiva per suonare il sassofono. Io, a quel tempo, avevo 16 anni e mi sembrava una impresa impossibile. Invece, il sassofono diventerà per me uno strumento di lavoro, uno strumento di vita. Grazie all’input che mi diedero Mingus e Adams». Stefano D’Anna riuscì a intrufolarsi due volte nello scantinato di Duca della Verdura per ascoltare «quella musica che aveva un impatto fisico sulle persone, un coinvolgimento emozionale», continua nel suo amarcord quasi rivivendo quelle sensazioni. Tre anni dopo, Mingus sarebbe morto. «Mi ricordo un uomo molto provato, appesantito, ma appena toccava il contrabbasso si percepiva la sua autorità musicale. Era inequivocabile. Le mani, tozze ed enormi, traevano suoni straordinari dallo strumento».
Stefano D’Anna, quindici anni dopo quel concerto, avrà l’occasione per suonare le musiche di quell’omone che aveva cambiato la sua vita. «Ero nell’orchestra che eseguì Epitaph a Palermo sotto la guida di Gunther Schuller. È stata una esperienza incredibile: la grande musica orchestrale di Mingus rivissuta attraverso l’ottica di un altro gigante come Schuller».
Il sassofonista palermitano resta più legato a quei due album che ascoltò eseguiti “live” nella sua città, fors’anche per un pizzico di nostalgia, Changes One e Changes Two, «due capolavori», sottolinea. «Un altro album che consiglierei è Mingus presents Mingus del 1960, in quartetto senza pianoforte con Eric Dolphy ai fiati, Dannie Richmond alla batteria e Ted Curson alla tromba. Un disco suonato come se fossero dal vivo, divertente, con straordinari momenti di fair play fra Mingus e gli altri musicisti».

Nello Toscano
Contrabbassista, compositore, 70 anni
«Mingus era un genio. Un pazzo, ma un genio», sorride Nello Toscano. Il contrabbassista catanese ebbe l’onore e l’onere di suonare il contrabbasso nella prima europea dell’affresco sinfonico di 120 minuti al quale Mingus aveva lavorato per la seconda metà della vita e che fu scoperto dopo la sua morte. Lo aveva chiamato Epitaph: un’epigrafe a se stesso e una denuncia delle incomprensioni che aveva subìto e provocato. La prima assoluta andò in scena il 3 giugno 1989 all’Alice Tully Hall di New York: fu eseguita da un’orchestra di trenta elementi diretta da Gunther Schuller e riscosse un successo trionfale. La seconda si tenne a Palermo nel ’91, poi Pescara e Roma, sempre con Schuller direttore. E quella sera al contrabbasso, dove solitamente stava abbracciato Mingus, c’era Nello Toscano. «Lui aveva una visione ampia, quasi sinfonica. Non a caso, molte sue composizioni erano lunghe suite».
«Mingus è stato un grande innovatore, sia come compositore sia per lo strumento», prosegue l’artista etneo. «È stato un divulgatore, ha svecchiato il jazz, portandolo ai giovani, caricandolo di significati sociali e politici. Era un genio anche nel rapporto con i suoi musicisti. Un rivoluzionario nelle sonorità e nei contenuti».
Come tanti musicisti della sua generazione, Nello Toscano ha scoperto il contrabbassista di Nogales negli anni Settanta con gli album Changes One e Changes Two, per poi andare a ricercare nel passato capolavori come Ah Hum del 1959, Pithecanthropous erectus del 1956, The Clown del 1957. «Senza dimenticare il disco Money Jungle, intestato a Duke Ellington con Mingus e Max Roach alla batteria e pubblicato nel 1963 o ancora Cornell dell’anno dopo del Charles Mingus Sextet con Eric Dolphy», sottolinea Toscano. «Lui favorì l’idea del workshop, musicisti che si riunivano per comporre liberamente. Non era free jazz, erano laboratori dove scambiarsi idee». A quei primi workshop parteciparono Max Roach, Thelonious Monk, Horace Silver, Art Blakey e il pubblico, che contribuiva all’elaborazione di nuove composizioni e arrangiamenti.
«Il suo contrabbasso aveva un suono duro», commenta Toscano. «Lui aveva studiato violoncello, aveva idee contrappuntistiche e voleva essere protagonista. Mingus guidava la performance, era il protagonista nel momento in suonava. Eppure, sapeva tirare fuori il meglio dai suoi accompagnatori».
«I miei metodi di lavoro utilizzano pochissimo materiale scritto», raccontava Mingus. «Io “scrivo” le composizioni su un foglio di spartito mentale, poi espongo la composizione parte per parte ai musicisti. Suono loro il “quadro” al pianoforte in modo che tutti abbiano familiarità con la mia interpretazione e il mio feeling e con la scala e le progressioni di accordi da usare. Viene preso in considerazione lo stile particolare di ogni persona. Vengono fornite loro diverse partiture da usare, ma scelgono le proprie note e le suonano nel proprio stile, dalle scale così come dagli accordi, tranne dove è indicato uno stato d’animo particolare. In questo modo posso mantenere il mio sapore compositivo nei brani e tuttavia consentire ai musicisti una maggiore libertà individuale nella creazione delle loro linee di gruppo e dei loro assoli».

Peppe D’Argenzio
Sassofonista, compositore e arrangiatore, 61 anni
«Mingus lo conosco e lo amo», esordisce Peppe D’Argenzio, jazzista di grande talento, fra i fondatori degli Avion Travel e componente storico dell’Orchestra di Piazza Vittorio, autore di musiche per il cinema, docente all’Università di Cosenza. «Mingus ha significato diverse cose per me», riprende il sassofonista campano. Innanzitutto, l’invidia per mio fratello più grande che era riuscito a vederlo dal vivo a Umbria Jazz con la formazione di Changes One e Two. I racconti di quella mitica esibizione li ho ascoltati fino alla noia. Proprio in quella formazione c’era George Adams, che è fra i sassofonisti che ho più amato. Io, a quel tempo, avevo 14/15 anni, da allora ho sempre ascoltato Mingus. Lui aveva una caratteristica, che era anche di Duke Ellington e Gil Evans, che la qualità della sua musica si basava sull’affiatamento con gli altri musicisti. Insieme con Danny Richmond formava una combinazione straordinaria, simbolo della libertà espressiva. Ti stupivano sia sul disco, sia nei concerti. Poi ho letto Peggio di un bastardo».
L’autobiografia di Mingus è stata lo spunto dello spettacolo PsycoMingus che l’Orchestra di Piazza Vittorio mise in scena nel 2011 alla Cavea dell’Auditorium di Roma con Fabrizio Bentivoglio (vecchia conoscenza dell’epoca degli Avion Travel con lo spettacolo La guerra vista dalla luna). «Proponeva gli scritti autobiografici del contrabbassista di Nogales. Fabrizio raccontava le ossessioni di Mingus, partendo dai concetti espressi in Peggio di un bastardo, la dimensione interraziale del musicista che sentiva di appartenere a diverse etnie, e c’erano diversi riferimenti a The Black Saint & the Sinner Lady», prosegue D’Argenzio. «E in quella occasione abbiamo compreso la difficoltà a riprodurre la musica di questo genio. Mingus è uno di quei musicisti più ardui da rifare. La sua magia sta anche nei rapporti di collaborazione che stabiliva con i suoi musicisti. Pensa al fatto che cadde in depressione quando perse Eric Dolphy che era stata la sua fidata spalla. La scelta dei musicisti era mirata».
Changes One e Two sono stati gli album su cui il sassofonista degli Avion Travel è cresciuto, ma sulla strada c’è un altro album del quale si innamorò perdutamente: Mingus di Joni Mitchell. Un album con una storia particolare. Il grande contrabbassista era rimasto incuriosito dall’ascolto della suite Paprika Plains contenuta nell’album Don Juan’s Reckless Daughter di Joni Mitchell, così decise di contattarla per proporle di ridurre e musicare i Quattro Quartetti di T. S. Eliot. La cantautrice di Laurel Canyon, dopo un iniziale tentativo, fu costretta a gettare la spugna, commentando ironicamente che «piuttosto avrebbe preferito musicare la Bibbia». Mingus, desideroso comunque di collaborare con lei, le propose allora di scrivere i testi su alcune musiche da lui composte in vari periodi della sua carriera, tra i quali anche la storica Goodbye Pork Pie Hat. Ormai gravemente malato, Mingus si spense in Messico prima che l’album venisse completato, ma, fece in tempo a sentire, secondo quanto la Mitchell scrive nelle note di copertina, «tutte le canzoni tranne una, God Must Be A Boogie Man: sono sicura che l’avrebbe fatto ridacchiare».
Esperanza Spalding
Bassista, cantante e produttore, 37 anni

«Mi piace il modo in cui senti la personalità di tutti nella sua band, anche quando è una big band. Anche se senti l’arrangiamento che chiaramente è stato scritto dalla sua mano su un pezzo di carta. E il risultato finale dell’arrangiamento è questo arazzo del suono e del modo di suonare di ogni individuo», commenta Esperanza Spalding, bassista e cantante statunitense.
«Penso che la sua trasparenza sia davvero significativa. La sua trasparenza su chi è e cosa pensava, cosa provava e di cosa era insoddisfatto. E per cosa si stava battendo e di cosa parlava nella musica. Sento che questo era il suo punto, farti sapere esattamente cosa diavolo voleva dire, ed esattamente chi era».
Fra le composizioni che l’artista di Portland ama «c’è la canzone per il sassofonista Eric Dolphy chiamata So Long Eric. Era il suo ultimo concerto con la band. Ricordo di averlo sentito quando ero piuttosto giovane, pensando: “Questo è un uomo adulto sul palco di fronte a persone che non conosce, che offre una canzone di desiderio, lutto e addio a un’altra persona che ama. È così generoso e radicale”. Che gesto d’amore profondo».