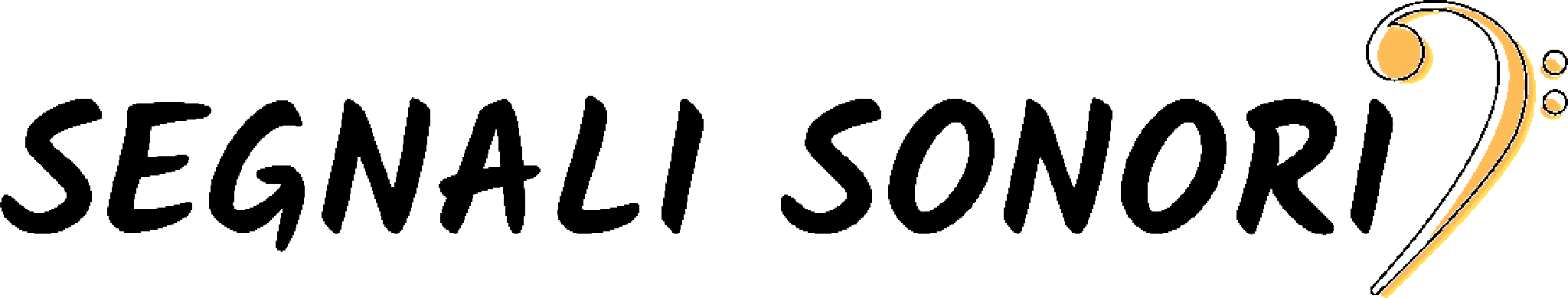A Milano il primo concerto del tour italiano. Nessuna concessione al pubblico, nessun classico, tira dritto per la sua strada che porta soprattutto all’album “Rough and Rowdy Way”. Vietato fotografare e telefonini “insacchettati”
È salito sul palco alle 21:45 ed è uscito alle 23:30. In totale, 105 minuti in cui non ha salutato né parlato. Ha borbottato tre o quattro “grazie” qua e là. Non ha suonato Like a Rolling Stone, né Knockin’ On Heaven’s Door, né Blowin’ in the Wind, né Hurricane. Insomma: non ha suonato alcuno dei suoi classici. Ha chiesto che mettessero il pianoforte (l’unico strumento che suonava) a quattro metri dal bordo del palco, dove si è rifugiato per tutta la notte. Era Bob Dylan o il suo riflesso? Chi lo sa. E, nonostante tutto ciò che è stato detto, è stato un concerto pesante, con molto da raccontare e lampi di bellezza. È successo ieri sera al Teatro Arcimboldi di Milano all’inizio del ciclo di concerti nel nostro Paese che, dopo la replica milanese, lo porterà il 6 luglio a Lucca, il 7 a Perugia e il 9 a Roma.
È necessario premettere che questa cronaca è priva di foto del concerto, perché Dylan non ha permesso accrediti stampa per fotografi. Quindi, le immagini con cui illustriamo il pezzo risalgono a concerti precedenti. Proibiti anche i telefoni cellulari, che tutti gli spettatori hanno dovuto mettere dentro sacchetti sigillati che venivano aperti solo quando la musica si interrompeva.

Questo Dylan crepuscolare, per niente compiacente, intimista, blues, invecchiato, a un certo punto anche giocoso, ha offerto un concerto fondamentalmente blues basato sul suo ultimo lavoro (il succoso Rough and Rowdy Ways, 2020) e non si è quasi guardato indietro. Era accompagnato da una buona band (batteria, due chitarre, basso e un altro musicista che suonava la steel guitar) che lo circondava e rimaneva quasi sempre statica, senza staccare gli occhi dalle mani del capo. Lui, sempre al pianoforte, in piedi, cantava, anche se quando non doveva usare la voce ne approfittava per sedersi qualche secondo e riposare. Ma è stato visto in forma a 82 anni. Firmeremmo tutti le sue cifre: fa una media di cento concerti all’anno.
L’ambientazione era sobria, con una tenda rossa sullo sfondo e poco altro. I musicisti sono usciti vestiti di nero e solo poche luci sullo sfondo hanno rotto il buio generale. Niente schermi. Dylan ha messo in scena uno spettacolo come se stesse dipingendo il quadro della sua vita su una tela. Ha parlato di muse, di cavalieri neri che percorrono una strada stretta, di uomini soli a cui manca la ragazza che gli ha spezzato il cuore, di attraversare il Rubicone nonostante i rischi che si corrono dall’altra parte… Dylan ieri sera ha raccontato la storia di Dylan nel modo più intimo. Come canta in I Contain Multitudes, il tema del suo ultimo album che ha offerto nella prima parte del concerto: «Interpreto le canzoni dell’esperienza come William Blake e non devo scusarmi perché tutto scorre».

La sua voce è piena di sfumature, con quelle sue inflessioni abituali, così imitate e con qualche ruvidezza che conferisce bellezza e verità allo stesso tempo. Nonostante l’usura, era pletorico. Ha tagliato il blues con una voce robusta e resistente. A volte una nebbia cupa sembrava raggiungere gli spettatori. Era la sua voce supplichevole in vecchiaia e piena di umorismo pungente.
Ha incluso quasi tutto il suo ultimo lavoro, Rough and Rowdy Ways, nel repertorio: canzoni come Black Rider, Goodbye Jimmy Reed, Key West e la bellissima Mother of Muses. E poi brani scelti da dischi come Nashville Skyline, dal quale ha estratto To Be Alone With You; John Wesley Harding, da cui ha selezionato I’ll Be Your Baby Tonight, o Slow Train Coming, dove ha scelto Gotta serve somebody. Ha fatto solo una cover, Not Fade Away dei Crickets, che suonava giocosa e in cui alcuni affermavano di aver visto Dylan scuotere la testa divertito. Potrebbe essere…

Per Bob Dylan sarebbe estremamente facile suonare una manciata di classici, essere affascinante sul palco, preparare qualche discorso banale e persino sorridere. Ma non appartiene a questo mondo mortale. Né vuole assomigliare a Mick Jagger o Bruce Springsteen, che danno al pubblico ciò che vuole. No: Dylan è scomodo, antipatico, ti farà soffrire e ti farà ripensare perché cavolo spendere 120 euro per essere lì ad aspettare Like A Rolling che non arriverà mai. Eppure, ne vale la pena. A questo punto della sua carriera, non c’è niente in gioco quando sale sul palco. Giochi per essere coerente con te stesso.
Ha concluso il concerto con Every Grand of Sand, un brano notevole del debole album Shot Of Love, dai suoi giorni cristiani. Un salmo tutt’altro che scelto a caso dove recita: «Nel momento della mia confessione, nell’ora del mio bisogno più profondo, quando la pozza di lacrime sotto i miei piedi inonda ogni seme appena nato, c’è una voce morente dentro di me che arriva da qualche parte». Che finale sensazionale: la voce morente che arriva da qualche parte. Un concerto da non perdere.