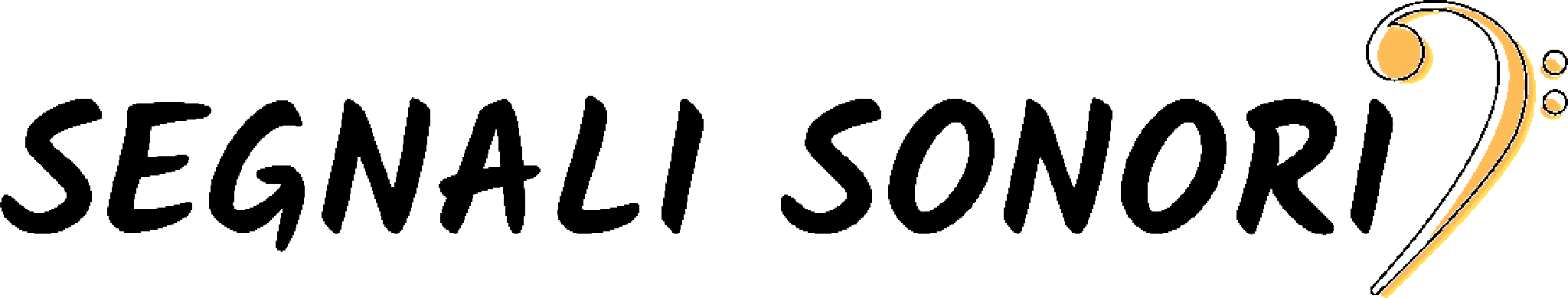Il leader della leggendaria The Band scomparso a 80 anni nel 1995 mise in scena l’album “Music for Native Americans” in prima mondiale nell’ambito della cinquantesima festa del mandorlo in fiore. Un atto di riconoscenza verso le sue origini e una cultura per secoli combattuta, isolata, discriminata

Nell’epoca in cui la sintesi tra generi diversi è l’elemento comune del mondo della musica, Robbie Robertson ha dimostrato come proprio seguendo le regole della sintesi è possibile rivalutare una cultura per secoli combattuta, isolata, discriminata. Robbie Robertson, il leader della leggendaria The Band scomparso a 80 anni, era figlio di un’indiana mohawk, era una star del rock e da venti anni sognava di realizzare un progetto dedicato alla musica dei suoi avi. Lo ha fatto con uno dei suoi album belli degli ultimi anni, Music for Native Americans, la cui musica ha portato in scena il 13 maggio 1995 ad Agrigento, in prima mondiale, in una serata al Palacongressi organizzata nell’ambito della cinquantesima edizione della festa del mandorlo in fiore.
Quella di Robertson era una musica intensa che ha i suoni delle origini ma che rispetta la contemporaneità: una «estensione», per usare le sue parole, della musica degli indiani d’America che diventa così un messaggio al mondo intero perché oggi la musica è uno dei più potenti strumenti di comunicazione della nostra società.

Il concerto di Robertson – solo sette pezzi per esigenze di riprese televisive – è stato tra i più emozionanti perché aveva in sé quelle caratteristiche di sintesi che sono alla base di tutte le più affascinanti proposte musicali di oggi, la capacità cioè di sviluppare su una base popolare un discorso moderno.
Quella di Agrigento fu una serata tutta dedicata agli indiani d’America aperta dall’“American indian dance theatre”. La scaletta musicale venne inaugurata da Buffy Sainte-Marie, cantautrice che racconta la disperazione e la tristezza del popolo indiano discriminato dai bianchi. Una tristezza che pervade anche la musica di John Trudell, secondo musicista in scena: Trudell ha un passato tragico alle spalle, i suoi genitori furono linciati quando era bambino. Nel suo recitar cantando racconta con efficacia e durezza le storie degli indiani d’America oggi, storie che dovrebbero far riflettere il mondo occidentale che sembra adesso riscoprire finalmente questa cultura preziosa che ha rischiato di estinguersi.
E proprio di questa cultura Robbie Robertson è diventato un simbolo con la sua capacità di trasfigurare e rendere universali una musica nata in una dimensione tribale. In scena, accompagnato da una band di sette musicisti, Robertson ha proposto nella maniera migliore i brani di un disco che è nato come colonna sonora per un documentario e che quindi in partenza poteva presentare delle difficoltà nell’eseguirlo dal vivo. Invece quella musica è diventata materia viva, emozionante, una vera e propria lezione di come parlando la lingua del rock e della fratellanza si possano lanciare messaggi importanti senza le regole della politica.
Un set ricchissimo, impreziosito dal contributo dei ballerini e concluso con un coro finale con tutti gli artisti in scena ad invocare la danza del coyote. Un concerto che è diventato una cerimonia e che dimostra come la musica non conosca più confini ed etichette precise ma che è tanto più valida, efficace e toccante quanto più mescola i generi senza tener conto di divisioni preconcette. La musica di Robertson è stata un omaggio sincero e indimenticabile agli indiani d’America e una serata come quella di Agrigento ha rappresentato un contributo importante a conoscere e rispettare una cultura che solo da poco l’Occidente ha imparato a conoscere e a considerare come un elemento vivo e non solo come uno scenario che rappresenta un universo morto rimasto nella memoria per i film della vecchia Hollywood.