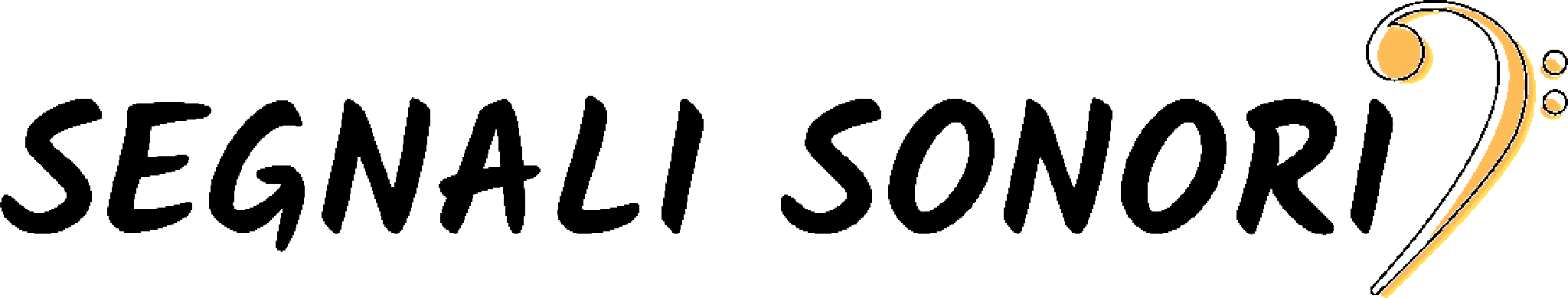Il prossimo 7 luglio esce “I Inside the Old Year Dying”: il nuovo album dell’artista britannica nasce dalle radici di “Orlam”, l’opera narrativa attraverso la quale Polly Jean ha superato i dubbi che l’hanno assalita durante un tour: «Avevo bisogno di recuperare me stessa, ma anche di rinfrescare la mia immaginazione»
Nel 2016 PJ Harvey era a metà del tour negli Stati Uniti del tour per il suo nono album The Hope Six Demolition Project, quando improvvisamente fu assalita dai dubbi: «Cosa sto facendo?», cominciò a chiedersi. Fu il regista Steve McQueen ad aiutarla a rimettersi in carreggiata sette anni fa. Il vincitore del Turner Prize stava girando a Chicago, dove Harvey stava tenendo un concerto, quando un amico comune ha rimesso in contatto i due dopo un fuggevole incontro negli anni Novanta. «Ho avuto una conversazione davvero meravigliosa con lui. Una vera chiacchierata filosofica», confida Pj Harvey, sottolineando la parola “filosofica”. «Mi ha incoraggiato a smettere di pensare alle canzoni sotto forma di album e mi ha consigliato di concentrarmi sulle cose che amavo: parole, musica e immagini. E di chiedermi cosa avrei potuto fare con queste tre cose. Sembra così semplice, eppure mi ha spalancato la mente. Mi sono sentita completamente libero».
Quella chiacchierata “filosofica” è diventata il primo passo verso il nuovo album di Polly Jean Harvey, I Inside the Old Year Dying, in uscita il 7 luglio. Perché non ci potrebbe essere I Inside… senza Orlam, il poema narrativo molto lodato della cinquantatreenne musicista britannica pubblicato l’anno scorso, nato dal suo trovare rifugio nella poesia, nelle parole, nelle immagini in quelle stanze d’albergo, durante quel tour. Scritto sotto la guida del poeta Don Paterson per un periodo di sei anni, Orlam è un’opera di un realismo magico scritta nel dialetto del Dorset: una storia di innocenza perduta ambientata nel villaggio immaginario di Underwhelem, e con un intricato micromondo di pub squallidi e bestialità. Il nuovo album costruisce questo strano universo, e agisce come una sorta di luogo di riposo, una correzione di rotta dopo le dimensioni del suo lavoro precedente.

«Avevo bisogno di recuperare me stessa, ma anche di rinfrescare la mia immaginazione», spiega. «Avevo davvero bisogno di ritirarmi nel suolo della foresta per vedere cosa c’è sotto le foglie». Con le sue radici nodose nel mondo terreno di Orlam, l’album I Inside the Old Year Dying è davvero una strana bestia; un gotico del West Country intriso di folklore, una danza intorno ai pilastri centrali del sesso e della morte. Nonostante i disordini politici degli anni trascorsi dall’ultimo album di Harvey, il suo sguardo risoluto e socialmente consapevole è stato sostituito con qualcosa di molto più insulare: un linguaggio narrativo ricco ma opaco.
Registrate nel corso di diverse settimane insieme ai suoi collaboratori abituali John Parish, Flood, Rob Kirwan e Adam “Cecil” Bartlett, molte delle canzoni sono adattamenti sciolti delle sue poesie messe in musica, alcune cantate dal punto di vista di Orlam, altre dalla parte dell’eroina di nove anni, Ira-Abel Rawles. Sebbene l’effetto complessivo sia molto più immediato e sanguigno di quanto sembri, non è certo un album pop. Infatti, Harvey non era nemmeno sicura che sarebbe stato un album. «Queste canzoni sarebbero potute diventare la colonna sonora di un libro, uno spettacolo teatrale o un’installazione sonora specifica per un sito. Inoltre, non sapevo se sarebbe qualcosa di buono».

I mondi sonori sconcertanti che Harvey e i suoi collaboratori hanno creato assicurano che I Inside… si regga da solo come un’opera d’arte. Impiegando registrazioni sul campo distorte (l’immagine che Harvey dipinge di se stessa, registratore in mano, mentre cattura il muggito delle mucche e il “vento nei fili”, è del tutto credibile) e sintetizzatori che sembrano «un incrocio tra una credenza e un centrale telefonica», l’effetto finale è destabilizzante. Il rombo simile a una macchina che apre la prima traccia dell’album, Prayer at the Gate, potrebbe essere una stampante a matrice di punti che si sta riscaldando, o un’antica fanfara di corno.
È naturale chiedersi quanta parte della sua educazione nel Dorset sia penetrata nel progetto. Nella contea del sud-ovest della Gran Bretagna, patria dello scrittore e poeta Thomas Hardy, PJ Harvey ha trascorso la sua infanzia negli anni Settanta tra le code e le campane di agnelli che suonano, vivendo un’esistenza bohémien e assorbendo la vasta collezione di dischi blues dei suoi genitori. «Penso che ogni artista, indipendentemente dal settore di lavoro in cui ti trovi, sia influenzato da ciò che conosce, ma sempre mescolato con l’immaginazione creativa».
Per quanto i confini personali di Harvey siano invalicabili, I Inside… si diverte a languire in spazi al confine fra la coscienza e la percezione, lungo terre di nessuno, come in The Nether-Edge, un brano che sposa un ritmo glam smorzato con un canto da parco giochi. «Ero interessata a suscitare la sensazione che non ci fosse davvero una chiara delimitazione», dice Harvey. «La vita non è in bianco e nero. Sono tutte le sfumature, tutti i grigi in mezzo». Indica un libro di poesie pubblicato nel 1971, Mercian Hymns di Geoffrey Hill, come una delle principali fonti di ispirazione. «Ha smantellato il modo di scrivere poesie e lo ha riformato. Ha infranto le solite regole della composizione narrativa, o della storia e del tempo. Stava mescolando il vecchio con il nuovo, mescolando il genere, mescolando le epoche. Non sapevi cosa stavi leggendo, chi stava parlando, ed è stato così emozionante».
L’abilità di Harvey di mutare forma, spesso verso fini inquietanti e drammatici, è stata una delle sue qualità più intriganti. Nel 1993, si è esibito in Rid of Me al The Tonight Show con Jay Leno. Sola e stranamente vulnerabile sul palco dello studio, cantava i suoi cori in uno strano miagolio diabolico. Poi, in White Chalkdel 2007, ha cambiato memorabilmente il suo ringhio blues e selvaggio con una voce di testa ossessionante. I Inside… vede ancora un altro cambiamento, l’album la spinge a esplorare i confini esterni della sua zona di comfort sotto le orecchie attente di Parish e Flood. Le hanno chiesto di incarnare qualcuno molto più grande di lei (Prayer at the Gate) o di cantare come un bambino che torna a scuola (Autumn Term). Il risultato è abbastanza diverso da qualsiasi cosa Harvey abbia fatto prima.
La carriera di Polly Jean Harvey iniziò nel 1988 quando si unì alla band di Bristol Automatic Dlamini insieme a John Parish, che sarebbe diventato il suo collaboratore più fidato. È un periodo a cui chiaramente ripensa con affetto. Ha lasciato la band per formare il PJ Harvey Trio con Rob Ellis e il bassista Ian Oliver, con cui ha registrato il doppio album di debutto Dry e il suo seguito Rid of Me, che ha spinto Harvey ad altezze stratosferiche, sostenuto dal fervore degli inchiostri rock dei magazine di musica. Canzoni sessualmente ambigue, come il mostruoso femminile rockabilly roller 50ft Queenie (“Sono lungo venti pollici!!”) e il succoso Man-Size, in cui Harvey incarna la mascolinità tossica. Successivamente, To Bring You My Love del 1995 inaugura la sua «fase acida di Joan Crawford».
«Penso che la gente abbia capito la tematica queer-non-queer sovversiva», dice. «Le immagini sono sempre state estremamente importanti per il mio lavoro, in particolare le immagini sul palco. Volevo abitare personaggi diversi e giocare con loro. È tutto nel processo di indagine e sfidare me stessa, capovolgere le cose e provocazione. Cosa succede se lo faccio? Cosa succede al suono? Cosa succede al’’arte? Cosa succede al modo in cui qualcosa viene recepita?».

Con il progredire della sua carriera, le svolte stilistiche sono diventate più nitide, gli album più ermetici, iconoclasti; dalle canzoni per pianoforte di White Chalkalla violenta e inquietante Let England Shake, con la quale ha vinto il suo secondo Mercury Prize diventando l’unica artista a vincerlo due volte (il primo è arrivato con l’album del 2000 Stories from the City, Stories from the Sea).
Poi è arrivato The Hope Six Demolition Project. Influenzato dai viaggi intrapresi da Harvey a Kabul, in Kosovo e, cosa più controversa, a Washington, DC insieme al fotografo e regista Seamus Murphy. Il linguaggio crudo e non ricamato del progetto forse aveva più senso se visto insieme al film di accompagnamento dell’album, A Dog Called Money. In effetti, Hope Six è stato oggetto di accese critiche, con molti che hanno contestato la decisione artistica di Harvey di adottare il ruolo di spettatore neutrale, freddamente distante o freddamente denigratorio di ciò che ha incontrato. Insomma, dove alcuni vedevano un tentativo di conciliare il reportage con la canzone d’autore, altri vedevano un turismo ad alta povertà.
Harvey, per sua stessa ammissione, è diventata più aperta quando è invecchiata. Puoi rilevare questo addolcimento anche altrove. In un’intervista del 1993 con Melody Maker, Harvey a proposito dei suoi testi commentò: «Non sono poesie, non sono pensate per essere lette». Una dichiarazione che ora sembra impensabile, quando la sua opera letteraria si è evoluta in un album.