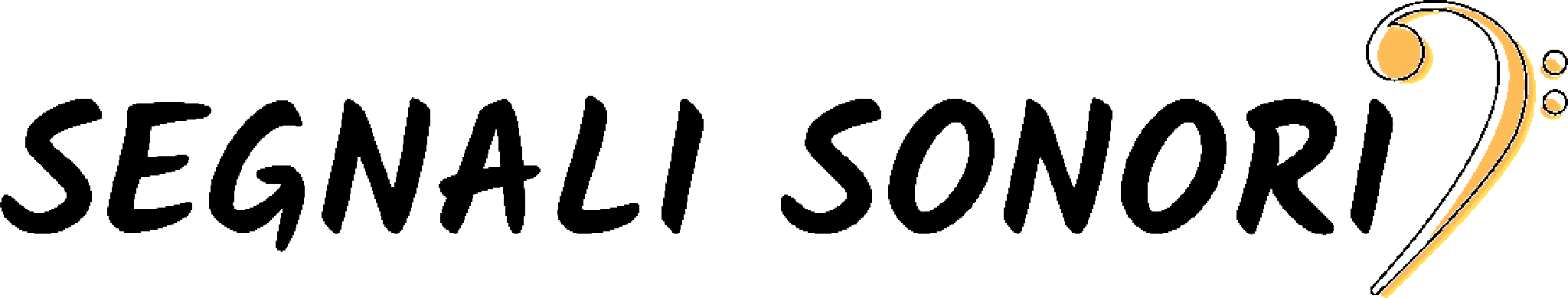– Il 5 aprile di trent’anni fa moriva il leader dei Nirvana. Ripercorriamo l’ascesa e la caduta di un angelo del rock attraverso i ricordi di Michael Lavine e Charles Peterson, i fotografi americani che hanno seguito la nascita del grunge
– «Era una persona gioviale. Non era preparato ad affrontare la fama». «Il momento più brutto? Quello della sua deriva: noi e la sua band rimanemmo sconcertati ed era difficile fotografarlo»
Il 5 aprile di trent’anni fa Kurt Cobain si sparava un colpo di fucile alla testa. Anche l’uomo simbolo della scena di Seattle entrava nel “Club 27”, come Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Amy Winehouse. Ancora oggi sull’ultima autentica rivoluzione del rock aleggia un alone spettrale, fatto da una lunga, troppo lunga, serie di morti precoci: quella di Andrew Wood, il carismatico leader dei Mother Love Bone, unanimemente riconosciuto come il fondatore del movimento grunge, il compagno di stanza di Chris Cornell e il suo amico del cuore, stroncato a 24 anni da una devastante dipendenza dall’eroina. E poi quelle di Layne Staley, il cantante degli Alice in Chains, di Scott Weiland, voce degli Stone Temple Pilots e poi dei Velvet Revolver, Mike Starr, bassista degli Alice in Chains, una catena di morti chiusa dal suicidio di Chris Cornell del maggio di due anni fa.
Kurt Cobain rimane l’icona più potente e, come spesso accade per i leader, anche quella che sintetizza un percorso collettivo. Kurt Cobain è, ed è stato, un’icona suo malgrado. Con i Nirvana era riuscito a sintetizzare quei fermenti musicali che si concentravano a Seattle rendendoli però universali.

«È la scena più eccitante prodotta da una singola città, come non accadeva dai tempi della Londra punk», sentenziava Everett True, il giornalista che ha coniato il termine “grunge”. «Brutto nome, nome zoppo, in realtà. Ma è piuttosto divertente nella sua zoppìa», ribatteva Thurston Moore, chitarrista, cantante e produttore discografico statunitense, famoso per la sua militanza nei Sonic Youth, autore del libro Grunge insieme con il fotografo Michael Lavine. «Come è possibile che una parola (“grunge”) che vuol dire schifezza, spazzatura, sporcizia, sia divenuta il nome di un genere musicale, una moda e un fenomeno pop?», si chiedeva sorpreso il New York Times nel novembre 1992. Quel “fenomeno” non è stato dimenticato. «La scena degli anni Novanta è stata forse l’ultimo grande respiro del rock», afferma lo scrittore Andrea Pomella. Il suo romanzo Anni luce è il racconto di una gioventù italiana che, come molte in quegli anni, ha vissuto un momento di simbiosi assoluta con la rivoluzione musicale del grunge. «Segnò una rottura completa con le sonorità che avevano caratterizzato il decennio precedente, da un certo edonismo e da una musica più facile e leggera», spiega Pomella. «Questo movimento proveniva dalla periferia dell’impero, da una città nel nord-ovest americano, Seattle, e sconvolgeva la scena con voci roche e aggressive che raccontavano di drammi familiari, di frustrazione e inadeguatezza, di una generazione che nutriva poche aspettative. Non è un caso che molti protagonisti si siano poi tolti la vita o siano scomparsi tragicamente».
SEATTLE, IL PALCOSCENICO DEL CAMBIAMENTO. Vista dallo Space Needle, la sua torre simbolo, Seattle si presenta come un grande affresco dove tutto appare perfettamente coerente: i grattacieli sbiaditi dalla pioggia a ovest del Puget Sound, i traghetti che trasportano auto e persone da una riva all’altra, le vette imbiancate di neve delle maestose Olympic Mountains. Minuscole insenature dedicate all’allevamento delle ostriche, piccole isole private, laghi che si alternano a lagune salate. Emerald city, la chiamano, gioiello incastonato in uno scenario naturale di baie, foreste e montagne sempre bianche.

Seattle è un mito. Sinonimo di Boeing e di Microsoft. «Città drogata di caffè», come ironizzava Cameron Crowe, regista di Singles, alludendo alla catena Starbucks che da queste sponde del Pacifico ha invaso il mondo. Seattle, capitale del grunge, cappuccino ed eroina, come disse con maggiore crudezza Courtney Love, cantante delle Hole e moglie di Kurt Cobain, pochi giorni dopo il suicidio del marito. Qui germoglia la nuova contro-cultura, o s’inventa il software.
Seattle ha apparentemente mantenuto lo spirito pionieristico dei suoi inizi. È la città simbolo del progresso (Boeing, Starbucks, Microsoft, Amazon), con un reddito alto a causa della presenza di molti manager e ingegneri, Seattle ha anche un numero record di senzatetto: circa 8.000 homeless (su una popolazione totale di 600.000 abitanti) vivono nelle strade o in tende in un’area periferica soprannominata “la giungla”. Le contraddizioni del sogno americano, per molti un incubo.

UN MOVIMENTO NICHILISTA. Qui, la Sub Pop – storica etichetta indipendente – negli anni Novanta riesce a dare visibilità a gruppi del calibro dei Mudhoney e dei Soundgarden, insieme ai Nirvana, cuore pulsante del movimento. Un movimento nichilista, che si sviluppa sullo sfondo di una pressante crisi economica che aveva messo in ginocchio la fiorente America, segnata ora dall’eroina e dall’Aids. È proprio in quell’America che nasce un nuovo suono per rispondere alle esigenze di quei giovani che non avevano più un punto di riferimento e che guardano al punk inglese, ormai passato e storicizzato, per trovare nuova espressione. Sono questi gli anni in cui nascono i primi movimenti giovanili no-global in risposta alla diffusione di multinazionali quali Starbucks o Microsoft. Il fotografo Michael Lavine immortala i Nirvana in studio in quattro diversi momenti, dai mesi della loro prima formazione, quando al posto di Dave Grohl alla batteria c’era ancora Chad Channing, fino agli anni del successo mondiale, quando accanto al leader della band c’era la moglie Courtney Love, regalandoci scatti diventati simbolo di un’era. Fotografie che, insieme a quelle di Charles Peterson sulla parte live dei Nirvana, hanno composto la mostra “Kurt Cobain & Il Grunge: Storia di una Rivoluzione”, che ha accompagnato l’edizione 2018 del Medimex di Taranto e che fu ospitata dal Museo archeologico MarTa.
DIMMI CHI ERANO I NIRVANA. «Kurt Cobain, a differenza di quello che si pensa comunemente, era una persona gioviale, felice, piena di vita» racconta Michael Lavine. «Anche Cobain, come Aristosseno e Archita, può essere considerato un mito», sottolinea il fotografo americano. «Fa bene la direttrice del Museo a dire che le sue foto stanno benissimo in questo contesto della Magna Grecia. Kurt era umile e quando ci conoscemmo lui disse a noi: sono felice di lavorare con due fotografi famosi come voi. Il momento più brutto? Quello della sua deriva: noi e la sua band rimanemmo sconcertati ed era difficile fotografarlo».

Come sono arrivati i Nirvana nella sua vita?
«Ai tempi avevo uno studio su Bleeker Street, dalla mia finestra si vedeva l’ingresso del CBGB’S. Fu lì che scattai i Nirvana per la prima volta. Erano di passaggio a New York e vennero da me. Non li conoscevo, erano una band piccolissima, sconosciuta, i Mudhoney erano famosi, loro no. Li rividi l’anno dopo, era il 1991 e stavano registrando Nevermind a Los Angeles: mi chiesero di andare lì a scattargli delle foto per l’album. C’era Dave Grohl, era il primo servizio fotografico per lui. Fu divertente, quando arrivai Kurt stava dormendo sul divano, mi fecero ascoltare Teen Spirit e ricordo che pensai: “Wow mi piace questa canzone!”».
Mentre scattava le foto a Kurt Cobain, era consapevole di essere di fronte a un’icona rock?
«Sono onesto: no. Prima dell’uscita di Nevermind se mi avessero chiesto se immaginavo che i Nirvana sarebbero diventati una leggenda, mi sarei messo a ridere».

Lei ha visto e raccontato per immagini l’ascesa ma anche la caduta di un angelo del rock.
«L’ultima volta che Kurt è venuto nel mio studio era nel ’92. Si presentò strafatto. La tensione era davvero alta. La band era davvero imbarazzata. Kurt dormì a lungo nel mio letto. Poi è svenuto su una sedia. Kurt era così distrutto da non riuscire ad aprire gli occhi. Se guardi le foto di In Utero, nella versione originale, c’è una di Kurt con i capelli rossi che si sporge verso la telecamera con gli occhi sbarrati. A un certo punto, mi disse: “Adoro Courtney perché è il tipo di donna che si alza in una stanza e distrugge un tavolo di vetro senza motivo. Mi piace molto di lei”. Non ho mai più fotografato Kurt. Durante quel periodo, era tutto incasinato. Non era preparato ad affrontare la fama».
L’ultima volta che vide Cobain?
«Fu nel novembre del 1993 perché mi invitò agli Mtv Unplugged, ero in prima fila. Finito il concerto andai a salutarlo nel backstage, stava meglio, non si drogava ma usava tantissime pillole per combattere la dipendenza».
«Il grunge è di certo bruciato in fretta» conclude Michael Lavine, ricordando la frase «meglio bruciare in fretta che spegnersi lentamente», scritta da Kurt Cobain nella “lettera d’addio”, quella che la moglie Courtney Love lesse ai fan sotto shock per la notizia del suicidio.
A ricordare quegli anni un po’ scomposti, quella generazione X, sigarette rollate in fretta e gli Mtv Unplugged guardati nella tv delle camerette, sono rimasti i Pearl Jam e Dave Grohl. Entrambi hanno però capito che il mondo ha bisogno di eroi vivi.