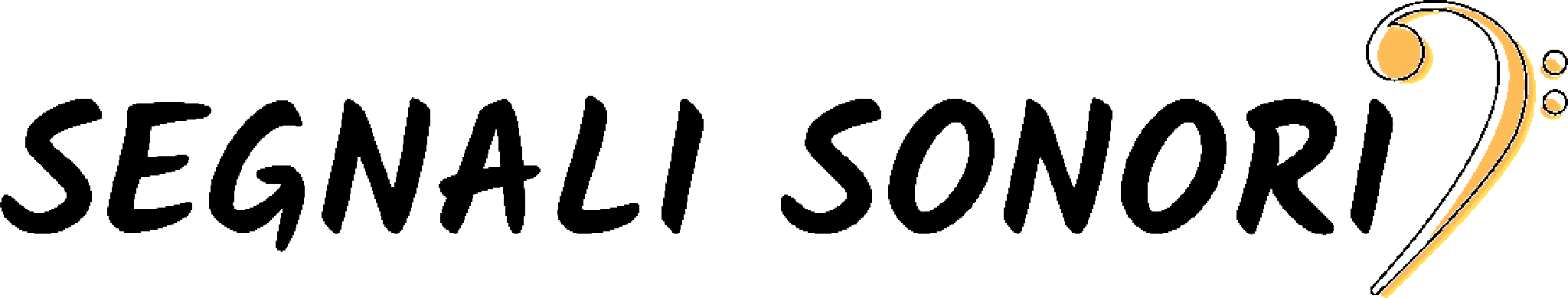– Il record di share (65,1%) per la prima serata è garanzia di successo: sarà una marcia trionfale per Amadeus fino alla serata finale (e d’addio?). Il suo Sanremo piace ai giovanissimi, in calo gli “over 55”
– La proposta musicale, fatte rare eccezioni, è però molto al di sotto della mediocrità. Spettacolo inesistente e la lunghezza della maratona canora è massacrante
– Una rassegna schiava dei social per conquistare la Gen Z. Inseguendo Spotify e TikTok, la musica, circoscritta a tre generi, viene ridotta da arte a numero. Azzerata la diversità culturale
Parte con il botto l’ultimo (?) festival di Amadeus. La prima puntata del Festival di Sanremo 2024 è stata seguita da 10,6 milioni di telespettatori per il 65,1% di share. Bisogna risalire al 1989 per trovare una partenza simile, al “Festival delle papere” dei figli d’arte Rosita Celentano, Paola Dominguín, Danny Quinn e Gianmarco Tognazzi. Battuto il record dello scorso anno, quando la serata inaugurale, caratterizzata dalla sfuriata di Blanco e dal monologo di Chiara Ferragni, era stata seguita da 10 milioni 757mila spettatori con il 62,4% di share. E, come è tradizione consolidata, una buona partenza è fondamentale per l’andamento delle altre quattro serate. Insomma, sarà una marcia trionfale per Amadeus fino alla serata finale (e d’addio?) di sabato.
Eppure, dopo la prima serata, sarebbero tanti i motivi per bocciare il sergente Amadeus salito agli onori di direttore artistico e conduttore. Il primo per la proposta musicale, che, fatte rarissime eccezioni, è davvero al di sotto della mediocrità. Il secondo per la mancanza d’idee e per l’eccessiva lunghezza che sembra ricordare la maratona di danza del film Non si uccidono così anche i cavalli?, nel quale il regista Sydney Pollack descrive un gruppo di disperati che cerca di guadagnare qualche soldo partecipando a questa gara che, sotto un’apparenza festosa, è in realtà massacrante. Una ragazza si rende conto dell’inutilità del tutto e chiede al suo partner di spararle, come si fa a un cavallo con la zampa spezzata. Un po’ quello che accade al Festival: un gruppo di disperati che cerca di guadagnare visibilità, qualche concerto, qualche comparsata in tv, insomma di guadagnare qualche soldo in più, partecipando a una gara massacrante, soprattutto per gli spettatori, dimezzati nella seconda parte: la prima, dalle 21:25 alle 23:31, è stata vista da 15 milioni 75mila persone, con uno share del 64,3%, la seconda parte, dalle 23:34 alle 25:59, da 6 milioni 527 mila spettatori, con uno share del 66,9%. Il tutto per qualche punto in più di share (quando, tra l’altro, la controprogrammazione è inesistente). Si punta sui numeri, piuttosto che sul gradimento (spettacolo debole, salvato solo da Fiorello).

La narrazione di questa edizione non è dettata dagli interventi della mamma di Giogiò o da quelli annunciati sulle vittime del lavoro o sulla protesta degli agricoltori («sacrosanta» fino a un certo punto), o dai temi di alcune canzoni, ma dai modelli di consumismo estremo. Che l’anno scorso erano rappresentati dagli influencer, da Chiara Ferragni e Fedez, mentre in questa edizione dai tiktoker, dagli streaming, dai follower, spesso usati per introdurre l’artista in gara.
Un Festival rivolto alla Generazione Z (“boom” nella fascia fra i 15 e i 54 anni, in fuga gli over 55). Ovvero a coloro che ascoltano la musica compulsivamente perché viziati dal mondo dei social e dello stile di vita che li vede costantemente connessi sugli smartphone. Hanno circoscritto la musica a tre generi principali: trap, rap e urban. Hanno ucciso tutti gli altri generi o nel migliore dei casi li hanno relegati a generi di nicchia. Hanno trasformato il cantautorato mono autorale artigianale e centellinato in una produzione industriale, a cadenza settimanale e prodotta se va bene a sei mani. Pur di scrivere ci si avvita a ripetere le stesse cose, gli stessi concetti e gli stessi temi. Gli artisti degli anni Ottanta e Novanta costretti a travestirsi di un abito urban o rap che non gli appartiene, che si rivolgono a producer, manager e autori lontani dal proprio mondo per paura di perdere posizioni e non rendendosi invece conto di perdere identità. Featuring o, per dirla secondo la lingua di Dante, duetti costruiti solo per aggregare numeri alla ricerca ancora una volta di streaming e certificazioni. Tutto è falso. Tutti lo sanno. Lo canta perfino Ghali: “Benvenuti nel Truman show / Non mi chiedere come sto / Vorrei andare via però”. Tutti lo dicono, ma nel nome dell’interesse comune, nel nome del Dio denaro tacciono e degli stream, accondiscendono e spesso facilitano. Discografici e radio in testa. E poi i media al completo, tutti proni davanti all’evento. «Sanremo è un mito che si autoalimenta, basti pensare che persino la sala stampa (l’amplificazione dell’evento) diventa parte della cerimonia», scrive Aldo Grasso sul corriere.it.
Spotify ha una responsabilità enorme in tutto ciò proprio per aver ridotto la musica da arte a numeri: ha azzerato la cultura musicale nel nostro Paese. Nel suo piccolo, anche il sergente Amadeus ha partecipato all’impresa.