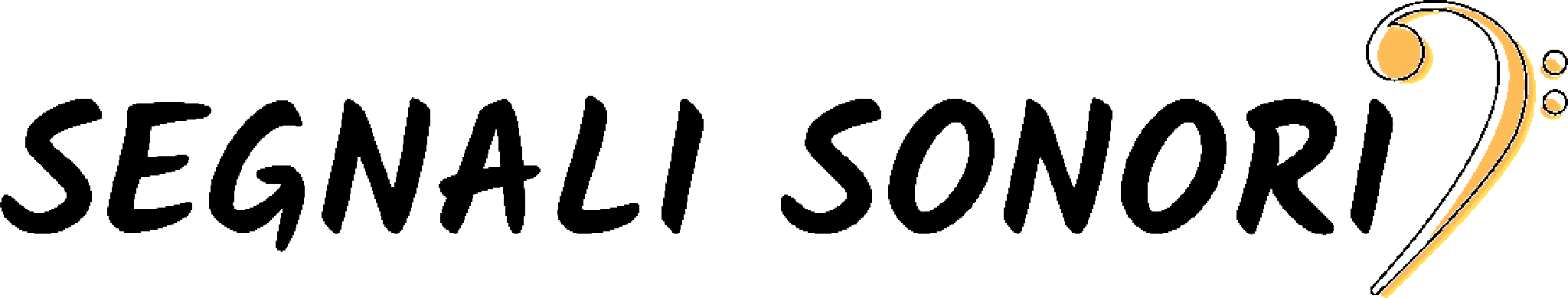Nei suoi concerti londinesi mescola i brani che preparano all’arrivo dell’uomo con la falce con alcuni del suo repertorio religioso. È un uomo che rinuncia al passato, che vive nel presente ed è senza futuro. A 81 anni ancora in tour sino al 2024
Il mondo è di nuovo in fiamme. Basta fermarsi a pensarci: paure che sembravano dimenticate stanno rivivendo ovunque. Guerra, intolleranza, disuguaglianza, fascismo… I barbari sono ancora una volta alle frontiere e il mondo è un luogo dove non vorresti stare quando non hai la forza per combattere. Bob Dylan, zoppicante e più fragile di prima di una pandemia in cui ha annunciato spudoratamente un tour fino al 2024, continua a suonare. Fermo nei suoi propositi e sempre dignitoso, è soprattutto un musicista che difende il suo mestiere: suonare, comporre, fare tournée, portare il circo e il messaggio a chi vuole ascoltarlo. Ma ogni giorno sempre meno persone sono disposte ad ascoltare.

Dylan e la sua ombra sono lì. Ancora. Sul palco del Palladium di Londra c’è un musicista che cerca di restare in piedi fino all’ultimo respiro, con gli stivali ai piedi, come se la fine fosse semplicemente un’altra parte del viaggio. A 81 anni, il musicista, vincitore del Premio Nobel per la Letteratura e che simboleggia come pochi altri la grande odissea del rock and roll del XX secolo, è più che mai lontano dal mondo di oggi. Lo è sempre stato, o almeno ha sempre voluto uscire dalla strada principale. Il suo incredibile transito in più di mezzo secolo di carriera artistica è testimonianza di una vita dedicata alla musica, di un’avventura indipendente che ha superato i propri errori e gli ostacoli degli altri. Dylan è forse il più influente e irraggiungibile dei colossi della controcultura. Dove tutti vogliono alimentare la fama, lui alimenta la leggenda.
La leggenda di Dylan è importante quanto la sua arte. Lui lo sa bene, e agisce di conseguenza: preservare il mistero del suo personaggio è prezioso quanto l’ambientazione. Continuare a rinunciare a ciò che è prevedibile o a ciò che tutti si aspettano è necessario. Dylan, anziano e ammaccato, è un musicista che non appartiene al mondo frenetico di oggi, ma non vuole nemmeno appartenere alla sua mera memoria. Dylan è un artista che oggi difende il suo libro di canzoni più recente, una raccolta di composizioni che riflettono sull’ultimo viaggio, quello di una persona per la quale tutto è passato, sebbene sia ancora presente. E nessun futuro.
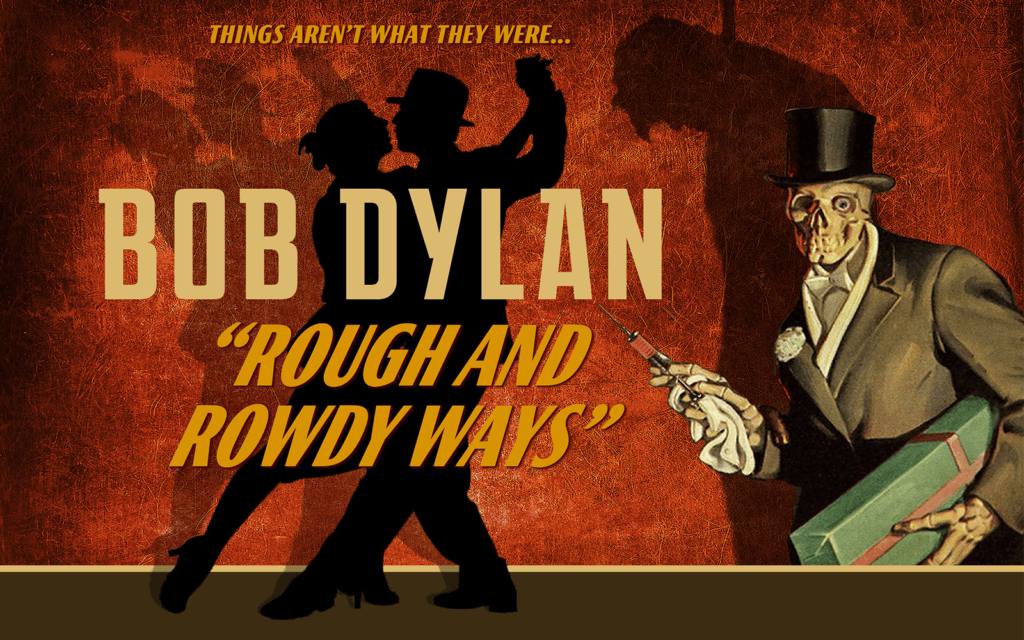
Dylan non è mai stato così lontano dal mondo attuale oppure è stato il mondo a lasciare Dylan. Entrambe le opzioni portano alla stessa conclusione: sei in un posto difficile da trovare. E avvicinarsi a quel luogo è ascoltare e osservare un uomo che dialoga con la morte. Il Dylan di oggi, quel vecchietto che non saluta il pubblico e fa fatica a dire qualcosa ai suoi concerti, struttura le sue esibizioni dando priorità assoluta a Rough and Rowdy Ways, l’album che, in onore del padre della musica country Jimmie Rogders e di tanti altri eroi delle origini della musica americana, rappresenta il suo testamento personale, la sua grande lettera alla memoria di una vita che si è spenta. A differenza di tutte le star del mondo, non fa esplodere la nostalgia a buon mercato con i più grandi successi. Piaccia o no, è innegabile che Dylan comunica sempre con le sue canzoni e continua a parlare al presente.
In questo modo, mescola quei brani che preparano all’arrivo dell’uomo con la falce con alcuni del suo repertorio religioso: inizia i concerti con Watching the River Flow e li chiude con Every Grain of Sand. Nel frattempo, canta Gotta Serve Somebody. Come al solito Dylan, secondo la filosofia di Picasso, ridipinge le sue opere migliori con occhi diversi. Sul palco, tutto si muove sui ritmi di un country-jazz o di un folk-swing, tra blues e rockabilly. Al fianco ha una band impeccabile, sempre attenta ad ogni suo gesto mentre lui siede al pianoforte come un anziano jazzista.
Quindi niente Blowin’ in the Wind, né Like a Rolling Stone, nemmeno All Along the Watchtower, la canzone più suonata di tutta la sua carriera concertistica. Niente Hard Rain o Masters of War, che si sarebbero adattate ai tempi. L’unica concessione è alla fine con Every Grain of Sand, una canzone di quarant’anni, rimodellata in un valzer cadenzato. Dopo aver pronunciato la strofa finale, si porta un’armonica alle labbra per la prima e unica volta. Ed eccolo. Quel suono, sollevato dal ruggito di gioia del pubblico, che va dritto al cuore ancora una volta.
“Quando giunge il tempo della confessione,
nel momento del più disperato bisogno
Quando la pozza di lacrime sotto i miei piedi
annega ogni germoglio appena sbocciato
C’è una voce morente dentro di me
che cerca di raggiungere qualcosa
si fa strada tra il pericolo
e le morali della disperazione.
Non sono solito guardarmi indietro
e ripensare ad ogni errore fatto,
come Caino, ora scorgo questa catena di eventi
che devo spezzare.
Nella furia di un istante,
riesco a scorgere la mano del Signore
In ogni foglia tremante,
in ogni granello di sabbia.
Oh, i fiori dell’indulgenza
e la malerba del tempo passato,
come criminali, hanno soffocato
il respiro della coscienza e del buon umore.
Il sole batte sui gradini
del tempo e illumina la strada
e riduce il dolore dell’ozio
e il ricordo del declino.
Alzo lo sguardo oltre la soglia
della furiosa fiamma della tentazione
E ogni volta che passo di lì
sento sempre chiamare il mio nome.
Poi continuando il mio viaggio
riesco a capire
che ogni capello esiste per una ragione
proprio come ogni granello di sabbia.
Sono passato dagli stracci alla ricchezza
nel dolore della notte
Nella violenza di un sogno estivo,
nel brivido di una luce invernale,
nell’amara danza della solitudine
che svanisce nello spazio,
nello specchio rotto dell’innocenza
di ogni viso dimenticato.
Sento gli antichi passi
come il susseguirsi del mare
A volte mi giro, e intravedo qualcuno,
a volte sono da solo.
Sospeso in equilibrio
nella condizione umana
come ogni uccellino che cade,
come ogni granello di sabbia”
(Every Grain of Sand, 1981, dall’album Shot of Love)