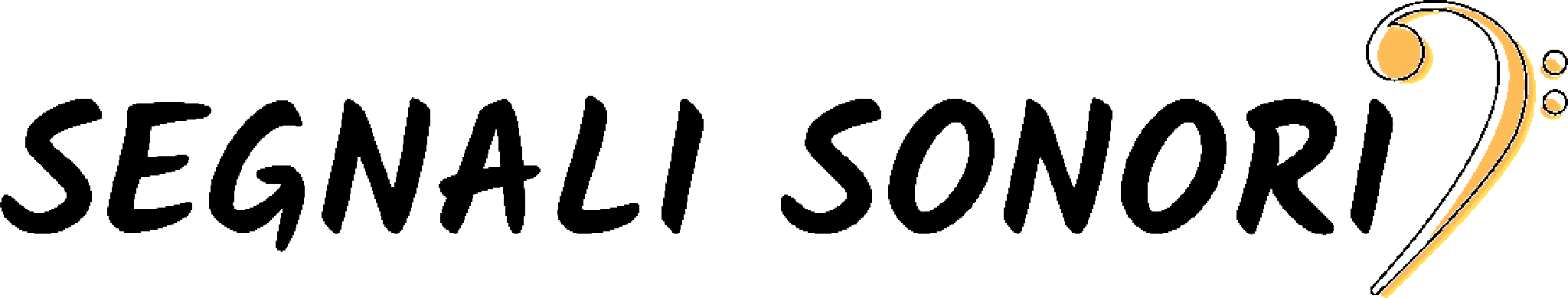– Dal 20 aprile al 24 novembre la sessantesima Esposizione internazionale d’arte della Biennale di Venezia, intitolata “Stranieri ovunque”
– Un murales di oltre settecento metri quadrati accoglie il visitatore all’ingresso sulla facciata del Padiglione Centrale ai Giardini
– “Migrazione” e “decolonizzazione” sono due delle parole chiave della mostra curata da Adriano Pedrosa, tra i Giardini e l’Arsenale
– Inaugurato fra le polemiche il Padiglione Italia, esperienza sonora che riempie i vuoti, colma gli spazi e apre prospettive più ampie sull’idea di arte
Un inganno, un tradimento di fiducia, all’origine della separazione tra popoli e luoghi diversi. È la storia di “kapewe pukeni” (il ponte-alligatore), il mito narrato dal collettivo indo-brasiliano del Movimento dos Artistas Huni Kuin (Mahku) nel murales di oltre settecento metri quadrati che copre la facciata del Padiglione Centrale ai Giardini.
L’opera è stata realizzata in occasione della sessantesima Esposizione internazionale d’arte della Biennale di Venezia, intitolata “Stranieri ovunque”, dal 20 aprile al 24 novembre. È un inno al colore, alle forme semplici di alberi, uccelli, pesci, terre unite da un gigantesco coccodrillo. In cambio di cibo, il suo dorso veniva usato dagli uomini per passare da una terra all’altra, ma quando gli fecero mangiare un piccolo suo simile, l’alligatore si infuriò e si inabissò. Un’opera di grande impatto nel suo sapore quasi naif. Una sorta di metafora se si pensa alle persone che si trovano a dover fare i conti con il distacco dalle origini, con il sentirsi “straniero”, con l’essere al di fuori dagli schemi tradizionali di un’appartenenza nazionale o di genere.

“Migrazione” e “decolonizzazione” sono due delle parole chiave della mostra curata da Adriano Pedrosa, tra i Giardini e l’Arsenale. Questioni che parlano di parti del mondo, in particolare il Sud America, per lungo tempo ai margini della storia scritta da altri Paesi cosiddetti sviluppati.
Si potrebbero però usare anche altri termini per raccontare la mostra, in linea idealmente con la Biennale di Architettura a firma Lesley Lokko centrata sull’Africa: “diaspora” (pensando ad esempio agli artisti italiani che hanno operato e vissuto fuori dai confini), “profughi”, “rifugiati”, “esiliati” oppure “indigeni”, se si fa riferimento ai tanti esempi di artisti che traggono linfa dalle loro tradizioni culturali, quasi tribali. Sembra svilupparsi come un’unica forma organica, con varie diramazioni interne, a volte senza netti confini, l’esposizione voluta da Pedrosa che ha scelto di articolare il tema attraverso i lavori di 331 artisti, in gran parte estranei ai complessi sistemi dell’arte contemporanea e presenti per la prima volta.

“Straniero ovunque” prende così forma, all’interno di due Nuclei tematici (Storico e Contemporaneo) con le opere che spaziano nel tempo e parlano linguaggi artistici di terre per troppo tempo lasciate ai margini, non euro-statunitensi, con molto tessile, pittura, scultura e poco digitale.
Pedrosa, primo curatore della Biennale Arte proveniente dal Sud America (Brasile) autodichiaratosi queer, ha sviluppato un percorso che da rilievo ad artisti queer, spesso messi al bando per il loro muoversi all’interno di più sessualità o generi, Outsider ai margini del mondo dell’arte, folk o popular, indigeni, trattati come “stranieri in patria”. Tra quest’ultimi, molti gli esempi di legami familiari, di lavori di genitori e figli: ad esempio Fred e Brett Graham o Santiago e Rember Yahuarcani.
«Questa edizione della Mostra ospita frammenti di bellezza marginalizzata, esclusa, punita, cancellata da schemi di geo-pensiero dominante», rileva in un passo del suo intervento in catalogo il neopresidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco. Evidenziando, tra l’altro, che Venezia «culla dolce di conoscenza e comunicazione tra popoli, etnie e religioni» è la piazza naturale «da cui smistare nuovi punti di vista e Fare Mondi, per dirla con un lessico qui di casa».

Ai Giardini e all’Arsenale – da una parte in italiano con la “schwa” al posto della “i” in stranieri dall’altra in inglese – accoglie i visitatori la scritta neon che dà il titolo all’esposizione opera del collettivo Claire Fontaine. Una sala del Padiglione Centrale, all’interno del Nucleo Storico, è riservata agli artisti italiani che hanno operato all’estero, specie nell’America Latina. Tanti nomi sono noti altri meno conosciuti. Muovendosi lungo un ideale percorso tra le due sedi, c’è solo l’imbarazzo della scelta per la varietà di lavori presentati, riuniti ad esempio in “Ritratti” (112 artisti per 39 Paesi) o “Astrazioni” (37 per 21 Paesi). Ampia la gamma delle opere e dei temi trattati. Bella la sala con i De Pisis, i suoi nudini, in rapporto con i dipinti di Fratino e Khakhar, o di Giulia Andreani con la potente infinita carta di Madge Gill. Ai Giardini c’è la tenda anatolica di Nel Yalter, il lenzuolo-sindone di Teresa Margolles con l’impronta di un giovane morto al confine tra Venenzuela e Colombia, il video di Alessandria Ferrini con l’incontro tra Berlusconi e Gheddafi, i dipinti e le carte di Aloise; all’Arsenale, le trapunte di Pacita Abad, Emma Whitehorse, Omar Mismar, Nour Jaouda.
I temi si rincorrono e sono legati strettamente alle declinazioni dare dal titolo generale. Ci sono anche punteggiature riguardanti la cronaca geo-politica. Su un gigantesco lavoro all’Arsenale compare la scritta “Viva Palestina” anche se parla di storie messicane; così come su un video nella sezione speciale dedicata a Disobedience Archive, un progetto di Marco Scotini, in questo caso centrato sulla diaspora e la disobbedienza di genere. Su un logo posto nella parte inferiore si chiede il boicottaggio del padiglione d’Israele. La realtà fa sì che la giornata della pre-vernice, con le foto di Pedrosa assieme al neopresidente Pietrangelo Buttafuoco, sia stata aperta dalla notizia che il padiglione resterà chiuso, per scelta del curatore e degli artisti, fino a quando non saranno liberati gli ostaggi a Gaza e in patria non ci sarà un cambiamento o il padiglione russo aperto solo perché ospitante la Bolivia.
Sul piano statistico, la sessantesima Esposizione Internazionale d’Arte registra la partecipazione di 87 Paesi, distribuiti nelle due sedi classiche dei Giardini e Arsenale e in ogni altra parte della città lagunare (la proposta tematica di Pedrosa sembra aver fatto breccia in molti casi nelle partecipazioni nazionali), oltre trenta eventi collaterali.

Questa mattina è stato inaugurato il Padiglione Italia, una esperienza sonora che riempie i vuoti, colma gli spazi e apre prospettive più ampie sull’idea di arte. Un progetto profondo, che ci porta ad accorgerci di come l’ascoltare sia anche una forma di tensione verso l’altro. Il progetto “Due qui / To Hear” è stato curato da Luca Cerizza e realizzato dall’artista Massimo Bartolini. L’installazione occupa tutti gli spazi dell’enorme padiglione italiano, compreso il giardino e lascia al visitatore la libertà di agire all’interno del panorama multisensoriale che si crea e modifica di continuo grazie alla relazione, all’interazione tra pubblico e opera. Le suggestioni della storia italiana, dalla musica all’architettura barocca dei giardini, si intrecciano con le filosofie orientali, creando uno spazio altro, accogliente, che suggerisce una parola come “spiritualità”.
«Secondo me non c’è familiarità con lo spirituale», spiega Massimo Bartolini all’agenzia Aska. «Ovvero quando se ne parla, lo spirituale viene assorbito da dei santoni, o dalla New Age o dalla religione. Non c’è educazione allo spirituale. In realtà lo spirituale è la condizione che tutti condividiamo e non sappiamo di condividere».
Si capisce, anche dalle parole dell’artista, che siamo davanti a un progetto sottile e rarefatto, a volte straniante, ma anche denso di potenzialità. Che se rinuncia alla presenza di “immagini”, cosa che ha infastidito alcuni benpensanti («Non mi piace, sono tubi innocenti», ha commentato Brugnaro, sindaco veneziano, fischiato dal pubblico), accetta invece di pensare all’arte da prospettive diverse, inserendosi in questo modo nel più ampio discorso sugli “Stranieri ovunque” del titolo della Biennale.

Se il Padiglione Italia, con Massimo Bartolini, a cura di Luca Cerizza, è all’Arsenale, il Padiglione della Santa Sede, che torna per questa edizione, e all’interno della casa di reclusione femminile alla Giudecca. Leoni d’oro alla carriera a Anna Maria Maiolino e Nel Yalter, mentre i Leon d’oro e d’argento sono andati al collettivo maori Mataaho come miglior partecipante e al Padiglione dell’Australia. Il collettivo neozelandese Mataaho espone all’ingresso delle corderie dell’Arsenale una enorme struttura metallica (realizzata nel 2022) che rimanda ai tessuti maori: sono un gruppo di artiste queer che si sono presentate in vestiti tradizionali. Il Padiglione dell’Australia, intitolato Kith and kin, realizzato da Archie Moore, per «aver realizzato in un albero genealogico, un archivio di lutto della storia: un inventario di migliaia di nomi tra quelli di 65mila anni di antenati dell’Australia». I visitatori possono aggiungerne altri.
Leone d’argento per miglior giovane a Karimah Ashadu, londinese di origine nigeriana (1985), che con un video «stravolge le distinzioni di genere»: sono migranti giunti a Lagos che operano come motociclisti e dei quali viene messa in mostra la loro mascolinità. Menzioni speciali alla palestinese nata a Gerusalemme Samia Halaby (1936), collegata da remoto, attivista, pioniera dell’arte digitale che dedica il premio «ai giovani che muoiono per documentare quanto avviene a Gaza» (è esposto un suo dipinto ai Giardini) e a La Chola Poblete con opere queer ma legate alle conoscenze ancestrali del Sudamerica: «Sono la prima artista trans e non bianca dell’Argentina che riceve riconoscimenti, sogno un giorno in cui saremo solo forma e nient’altro».